
L’ARTE DI PESTARE QUALCUNO.
Voi credete che questo sia bullismo? Voi credete che ragazzi crudeli abbiano preso di mira uno e gli facciano le peggiori schifezze?
Io credo di no. Credo sia tutta un’altra cosa. Forse il mio sguardo è viziato dalle scuole d’arte che ho fatto, forse è viziato dal fatto che nel tempo ho frequentato artisti, diciamo, non dal pensiero più lineare e immediatamente collocabile, ma questa no, non è una semplice, crudele, sporca storia di bullismo.
Il contenuto si riassume molto velocemente: un ragazzo seduto in una stanza riceve in successione azioni, insulti fisici e non, da parte di altri ragazzi che si alternano.
Quel che vediamo è un esperimento sul piano sociale di un progetto artistico. Il performer si mette a disposizione del suo pubblico. È molto probabile che il progetto artistico sia stato ideato proprio dal ragazzo che viene sottoposto alle azioni degli altri e cioè degli spettatori. Potenza dell’arte, l’attore principale subisce ma ad agire non sono i protagonisti, anzi, sono delle semplici, sostituibili comparse. Mentre chi subisce sembra essere sottomesso, come le azioni affermano, in verità lui è il fautore, il creatore delle azioni e dei destini dei suoi aguzzini.
“Rhythm 0” è stata una delle performance più scioccanti di Marina Abramović. realizzata nel 1974. Lei si è messa in piedi immobile per sei ore in una galleria d’arte, lasciando che il pubblico facesse di lei ciò che voleva con 72 oggetti messi a disposizione. C’erano cose innocue, tipo una piuma o un rossetto, ma anche oggetti pericolosi, come coltelli e persino una pistola carica. All’inizio la gente era timida, e imbarazzata ma poi si è scatenata: le hanno tagliato i vestiti, l’hanno ferita e le hanno puntato una pistola addosso. Lei non ha mai reagito, dimostrando come la violenza possa venire fuori quando le persone pensano di poter fare ciò che vogliono senza pagare le conseguenze.
Questo ha molto in comune con il video di “From The Sun”. Anche qui il protagonista non reagisce mentre gli altri lo umiliano, trattandolo come un oggetto. Nel videoclip, come in “Rhythm 0”, la violenza cresce poco a poco, dentro un contesto che sembra giustificarla (l’arte, il gioco, la performance).
Sia la Abramović che il ragazzo del video ci fanno vedere qualcosa di disturbante: se una persona smette di opporsi, gli altri si sentono in diritto di spingersi sempre più in là. E questa, purtroppo, è una verità piuttosto inquietante sulla natura umana.
Quindi quella è arte. Il protagonista non è una vittima ma un performer e quel che vediamo è solo un’opera, una rappresentazione artistica e metaforica della realtà.
Comunque sia, la violenza è violenza. L’esperimento artistico, per quanto performatico, agisce comunque con il cervello più antico dentro la nostra testa.
Avete mai sentito parlare dell’esperimento di Stanford? No? In un contesto sperimentale, con il pretesto di una ricerca scientifica alcuni studenti, divisi in carcerieri e prigionieri in una simulazione, si abbandonarono a crudeltà e umiliazioni senza che nessuno imponesse loro di farlo. Bastò assegnare i ruoli e lasciare che il gruppo, lentamente, scivolasse nella spirale dell’abuso. Il potere non era nei singoli individui, ma nel sistema che si era creato. E proprio come in quell’esperimento, qui non c’è un leader, non c’è un ordine esplicito. C’è solo un gruppo che si autoalimenta nella violenza, accrescendo il proprio potere nel silenzio della vittima.
C’è un librino francese del 1895 che analizza come gli individui, quando si trovano in una folla, perdano il senso di responsabilità e diventino più impulsivi, emotivi e irrazionali. Sostiene che la folla ha una sorta di mente collettiva, in cui il singolo si dissolve, seguendo dinamiche quasi primitive di contagio emotivo. Si intitola “Psicologia delle folle”, dove il suo autore Gustave Le Bon aveva già descritto questa metamorfosi dell’individuo nel gruppo. L’anonimato e la massa dissolvono la responsabilità personale, amplificando l’istinto, spingendolo a gesti estremi.
Anche nel video si vede questa dinamica da folla: nessuno degli studenti da solo probabilmente si comporterebbe così, ma all’interno del gruppo si sentono giustificati, come se la responsabilità fosse distribuita e diluita. Il protagonista è trattato come un oggetto, non come una persona, perché nel branco si perde la percezione della sofferenza dell’altro.
Qui ci sono due piani astratti che rendono incerta la comprensione della realtà e di quel che accade per noi spettatori: uno è quello del video che documenta la performance, facendo credere ai partecipanti che tutto sia finto. L’altro è l’idea che questa azione sia un progetto artistico, una performance che agisce sul piano simbolico e metaforico, il che dovrebbe far credere, ancora una volta, che tutto sia finto. Ma non c’è scampo: la violenza scatta comunque. La violenza è comunque vera e presente anche se tutto è finto.
È come se un gruppo non riuscisse mai a tollerare e trovare sopportabile il limite. Sembra che il gruppo, anche nella finzione o nella metafora di un’azione artistica, mal sopporti chi non reagisce, assegnando a questa debolezza e accettazione la responsabilità di ciò che accade.
Il gruppo opera violenza progressiva, auto-autorizzandosi alle aggressioni. La gradualità della brutalità sembra legittimata dalla quantità di violenza precedente. Si inizia con una carezza per passare al fastidio di sciogliere le scarpe, poi si arriva allo sputo in faccia, seguito dal pugno o dalla spinta che lo sbatte a terra. Se il pugno o la spinta fossero stati all’inizio, probabilmente il gruppo l’avrebbe registrato come eccessivo, ma un pugno alla fine ci sta: lui non reagiva… è colpa sua.
Il gruppo non è la somma delle parti, ma è un’entità a sé. La folla ha una mente collettiva, un istinto proprio che trascende il volere dei singoli, come ci insegna la psicologia sociale.
Ora mi chiedo: cosa rimane dentro l’artista? Cosa registra la sua esperienza? Magari era preparato a questo evento, ma di sicuro ha ottenuto la conferma che il branco è crudele, che le persone in gruppo sono feccia. Forse l’artista accetta un sopruso “artistico” come questo solo perché ha già in odio il gruppo e con questa ferita autoinflitta ne ha solo riprova e conferma.
Che sia arte o vita consueta, la verità è che, mentre recitiamo la nostra parte, la brutalità si insinua tra le righe della nostra indifferenza e un po’, siamo tutti colpevoli…
UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA. RICK ALVERSON. 2013.
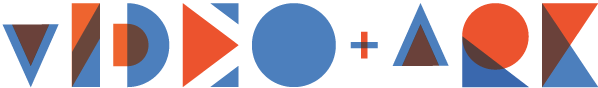
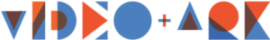

Ciao bella recensione come al solito!
Volevo solo aggiungere che probabilmente Marina Abramović a sua volta penso si sia ispirata a Yoko Ono e alla sua performance del 1964 Cut Piece. Un mito!
Grazie mille, StillArte, per aver arricchito il nostro discorso con questo prezioso dettaglio storico!
Sì, è vero che Cut Piece di Yoko Ono precede di dieci anni Rhythm 0 di Abramović. Cut Piece è un esempio emblematico dell’arte concettuale, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza profondamente emotiva e riflessiva. La sua minimalità e semplicità, che coinvolge il pubblico offrendo un paio di forbici nel taglio dei vestiti di Yoko Ono, creano un’atmosfera intensa e riflessiva. Al contrario, Rhythm 0 introduce un elemento di imprevedibilità e violenza più esplicita, con 72 oggetti a disposizione del pubblico, ampliando la gamma di possibili interazioni. Indubbiamente Abramović è debitrice a Yoko Ono.
Yoko Ono è stata una delle pioniere dell’arte performativa e ha fatto parte del movimento Fluxus, che considero, dopo Dada, uno dei più potenti e straordinari nella storia dell’arte.
Grazie ancora per questa aggiunta colta e per me stimolante…