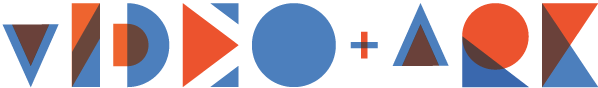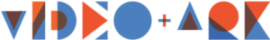IL FUOCO DOPO LA FINE.
È già lampante dalla primissima immagine che il mondo creato da Rick Farin. Claire Cochran e Case Miller, col supporto artistico dello studio sperimentale losangelino Actual Objects, sarà tutto fuorché rassicurante.
La figura del protagonista – nella sua scheletrica sofferenza, nel suo mostruoso make-up da musicista underground autolesionista, nella sua innaturale volumetria, nella sua virata cromatica al rosso opprimente – è un efficace pitch atmosferico che scaraventa lo spettatore in un trip visionario dove i lampi del passato e l’orrore del presente si tempestano reciprocamente, annientando le prospettive sul futuro.
Dalle viscere della terra, così disgustosamente simili alle interiora di un corpo umano, l’occhio della cinepresa (o l’occhio dell’anima) sale verso la luce dell’esistenza, aprendo un varco sulla vita del nostro singolare personaggio.
Quasi fosse condannato sin dalla nascita a uno stato di emarginazione sociale ed emotiva, il bebè si dimena nella sua culla sfoggiando di già un visino dipinto di bianco e di nero.
Scorgiamo tra le foto di famiglia i visi truccati dei suoi genitori. Più che cerone e pittura, quelli sembrano gli effetti di una strana e incurabile malattia della pelle, riflesso di disturbi più gravi e intimi, che vanno tramandandosi di generazione in generazione.
Ma c’è qualcosa di ancora più inquietante nell’aspetto di questo bimbo in salsa Gene Simmons: non è una persona reale, ma un’animazione in 3D trapiantata in un universo live-action. Alla stregua di un bizzarro surrogato digitale di Roger Rabbit, questo strambo pupazzo in CG, irrealistico e inespressivo quanto un androide, si presenta come la quintessenza dell’uncanny. Anche peggio della locandina di The prodigy – Il figlio del male!
La sua quotidianità trascorre nella monotonia emozionale di un disadattato: circondato dai cordoni gialli di una scena del crimine, se ne sta fin da piccolo solitario e inerte, appollaiato su un albero a contemplare la vuotezza che lo attornia; nei suoi occhi spenti si riflette la morte sul rogo del suo peluche del cuore, abbandonato tra le fiamme del caminetto.
Gli anni passano, e il nostro ragazzo (sempre nella forma di automa animato) cresce e vive: conosce l’amore e le delusioni affettive, incontra gli amici e li perde quasi programmaticamente; ogni sconfitta personale diventa un segno indelebile sul suo corpo, un rattrappimento spirituale, di cui non è facile discernere cause ed effetti.
È come se nei suoi geni fosse marchiato l’indirizzo della solitudine, una condanna senza possibilità di appello, il triste orizzonte di un’umanità alla deriva.
Gli intervalli temporali vengono scanditi da brevi flash-forward direttamente dall’impero della mente: torna il rosso angoscioso dell’incipit, che avvolge una selva desolata dai contorni infernali; qui langue il protagonista, nell’attesa di una fine ineluttabile. O forse la fine è già avvenuta. Potrà mai esistere la fine dopo la fine?
Certo che vedere la nostra rockstar mancata scrutare mestamente un lettino dell’obitorio, senza che l’identità della salma ci sia rivelata, ispira ipotesi necrologiche e metafisiche di un certo calibro.
E così, mentre la foresta tinta di rosso comincia a prendere fuoco, seguendo l’ascesa del climax strumentale dell’autore Shlohmo, abbiamo la sensazione di assistere alla definitiva dannazione di un’anima perduta, forse un incubo post-mortem, forse un assaggio ultraterreno. Le fiamme fagocitano il limbo alberato della coscienza tormentata del protagonista, intrappolandolo nei suoi stessi deliri depressivi, nella sua stessa patologica incomunicabilità.
Ma l’istinto di sopravvivenza, che qui assume i toni di un innato perseguimento della serenità interiore, mette le ali ai piedi del nostro, che fugge dall’incendio famelico, diretto verso i flutti salvifici di un lago. I flash delle sue memorie si frantumano come esplosioni sinaptiche sullo schermo, l’uomo cambia età e aspetto senza soluzione di continuità, e corre, corre a perdifiato.
E infine le acque. Il dissolvimento. Il culmine di sforzi e ansie perso fra le increspature del nulla.
La pace.
Ma il rosso che imprime l’aria permane, spietato e asfissiante.
Può la pace avere lo stesso colore del sangue?
SHLOHMO. RICK FARIN & CLAIRE COCHRAN, CASE MILLER. 2020.