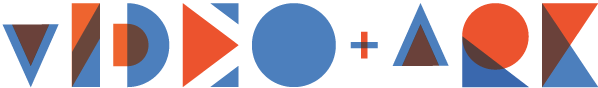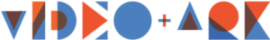IL TERRORE DEL CANDORE.
Un montaggio frastagliato e sulle prime indecifrabile funge da ponte introduttivo su un video analogamente criptico, costruito sulla forza suggestiva delle immagini molto più che sulla prosaica saldezza della narrazione.
Si tratta perlopiù di singoli particolari e dettagli – mani sporche di terra o immerse in un corso d’acqua, strani monili di fattura preistorica, rami dalla forma irregolare grossolanamente sfrondati – o di brevi istantanee umane che variano dai primi piani ai mezzi busti, il tutto immerso nell’intrinseca astrusità dell’effetto ralenti.
Eppure, anche con pochi elementi su cui fondare un’intuizione interpretativa dello scenario, è chiaro sin da subito il clima che il regista Janiv Oskár intende evocare, e non è certo dei più rasserenanti.
Bisogna altresì precisare che la colonna sonora offerta dal brano degli Oranssi Pazuzu accentua notevolmente l’atmosfera di straniamento e angoscia: il ritmo lento e incalzante, la crudezza delle chitarre, il favolistico coro di vibrafoni che riporta alla memoria i Goblin di Suspiria… Dal bucolico allo stregonesco, il passo è breve!
Location nordiche, tra boschi innevati e vegetazioni spoglie, una fotografia opportunamente fredda, un fumo di origine inesplicata serpeggiante in mezzo agli alberi, il bianco onnipresente che richiama effluvi di purezza e al contempo raggela le vene sotto la pelle: in questa cornice ambientale si delinea, inquadratura dopo inquadratura, un dipinto di misticheggiante inquietudine e onirico fascino.
Rimarcando tali sentori di intangibile disagio, le occasionali rotture cromatiche che il videomaker inserta nel corso del viaggio, tra il caldo pallore di un fuoco e l’intrusiva irrealtà abbagliante di fumogeni variopinti, deviano subdolamente il pubblico da una qualsiasi contestualizzazione logica e cronologica.
I soggetti che poco per volta si palesano sullo schermo esibiscono gestualità e vestiari avulsi dalla contemporaneità, persi in remote tradizioni spirituali di cui neppure si potrebbero rintracciare le origini, portavoce di sentimenti antichi che – forse proprio per la loro alienità figurativa e idealistica – cacciano brividi lungo la schiena.
Una giovane donna con indosso un abito bianco (tanto per cambiare!) giace appena sotto la superficie di un chiaro laghetto montano, circondata da foglie galleggianti e con un calice fra le mani; un uomo nelle sue stesse condizioni sprofonda nell’oscurità dello specchio d’acqua; individui in abiti folkloristici se ne stanno dritti in piedi con i visi coperti da fasci di ramoscelli o bizzarre maschere campestri d’ispirazione pagana; un ragazzo incappucciato si lancia in convulse preghiere spargendo fumi arancioni e viola nell’aria.
Altri individui – o forse proprio i suddetti, magari in una fase successiva del loro strano rituale – occupano una radura bislaccamente allestita: sulla schiena nuda di una ragazza, legata a una struttura di tronchi e col viso coperto, viene pitturato un simbolo pseudo-massonico; un giovanotto prende la mira col suo arco artigianale e punta una freccia nodosa al disegno arcano, come in un macabro tiro al bersaglio; un altro se ne sta seduto a un tavolino su cui arde una padella usata a mo’ di braciere.
Insomma, si respira un’arietta folk horror degna di The wicker man!
È la stessa ragazza in abito bianco ad assistere all’insana cerimonia, al contempo silenziosa testimone e parte integrante dell’evento.
In concomitanza col climax sonoro della canzone, la seconda metà del video riceve un’impennata grafica ed emotiva, esplodendo in visioni da incubo, mondando la nitidezza degli sfondi a suon di liquami scuri e giochi luminosi dai riverberi psichedelici: gli alberi sanguinano e macchiano di rosso venoso la neve, i vapori si frantumano in centinaia di allucinanti cristalli blu, il calice stretto dalla ragazza in bianco vomita fluidi marcescenti.
Nell’enigmaticità simbolica dell’insieme, lo spettatore si può sbizzarrire sulle chiavi di lettura da adottare.
Un rito di passaggio verso mondi inesplorati, al limite del sovrannaturale?
O la concretizzazione visiva della perdita dell’innocenza, dell’eutanasia di una verginità? Chissà, considerate le sonorità violente e cupe del pezzo in esecuzione, magari ottenuta senza il consenso della povera “iniziata”…
Oppure, banalmente, il conturbante sogno lucido della protagonista durante un bagnetto soporifero, come la rivelante vuotezza del finale lascerebbe supporre?
Ma in fondo, trascurando metafore e allegorie, non serve lambiccarsi il cervello in analisi e supposizioni per godersi la nera magia di un trip videoclipparo nella sua schietta essenza.
ORANSSI PAZUZU. JANIV OSKÁR. 2016.